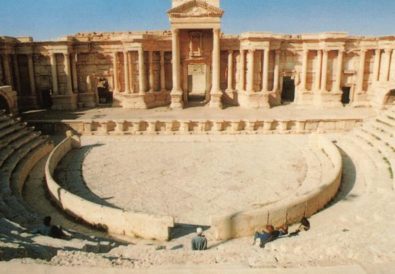Stiamo assistendo in questi giorni ad un feroce dibattito sulle violenze subite, decine di anni fa, da attrici nello star system. In Italia la discussione si è avviluppata sulla natura delle violenze, sul ruolo delle vittime e sull’opportunità di denunciare.
Ancora una volta il nostro Paese (e, duole constatare, molte donne) si identifica nella morale del “te la sei cercata” ribaltando ruoli, gettando le vittime sul banco degli imputati, rovesciando le responsabilità.
La cosa che colpisce, oltre all’involuzione della mentalità che non si discosta da ciò che un film nel lontano 1988 ci raccontò o dalle sedicenti teorie, sviluppate nelle aule di tribunale, sul confine della violenza giocato dal tipo di abbigliamento indossato, è che, ancora una volta, non si discute del fatto criminoso o del criminale che lo ha compiuto, bensì ci si concentra ed appassiona solo nel giudizio morale e moralizzatore sulle vittime.
E questo è uno scandalo nell’aberrazione.
È pur vero che solo dal 1996 il reato di violenza sessuale è riconosciuto come violenza alla persona e non contro la moralità pubblica e il buon costume, ma non esistono altri delitti in cui le circostanze assumano maggior rilievo del fatto materiale, dove la responsabilità venga distribuita tra vittima e carnefice, dove la pena morale venga inflitta per via di ammiccamenti, domande irrispettose, oscene che violano l’intimità della vittima, minando psicologicamente chi si sente in colpa di aver provocato e non, invece, aver subìto l’evento.
La violenza assume forme molteplici a seconda delle situazioni in cui viene manifesta.
La vita è complicata, le relazioni sono complesse e non esistono copioni puliti in cui gli attori si muovono. Non esistono vittime perfette, miti, dimesse, inconsapevoli, in grado di opporsi con fermezza a qualsiasi situazione abusante, in modo da non essere fraintese o accusate di vittimismo, isteria o protagonismo in un secondo momento. Esistono le persone che non sempre hanno forza, coscienza, maturità, talvolta consapevolezza, per affrontare la violenza nella sua poliedricità.
La sperequazione di potere tra le parti, dove ancora oggi, statisticamente, vede l’uomo dominante, e il consenso sociale che ne deriva, crea una barriera di protezione, giustificazione e accettazione quasi insovvertibile. Anche da parte delle donne. Anche da parte delle vittime che si trovano nel dilemma se entrare nella spirale del sistema, e trarne apparente vantaggio, o sfidare il muro dell’omertà, del pettegolezzo e della gogna virtuale, mediatica o, semplicemente, uscire dall’ombra ed additare l’aguzzino, anche se tardivamente, anche se con un virgulto di autostima a posteriori.
E la scarsa tolleranza verso chi ci prova conferma il gelido silenzio in cui le vittime spesso si trincerano (80,9%) e l’assenza di denuncia (0,5% fonti: ISTAT, indagine sulla sicurezza dei cittadini).
Ma perché non scatta la solidarietà dovuta? Perché proprio tra le donne manca la sorellanza che potrebbe fare la differenza sovvertendo i paradigmi di riferimento di cui la violenza si nutre?
Ricusare l’immedesimazione è necessario per radicare le proprie certezze. Pensare di avere il potere di rifiutare, di evitare l’abuso, il compromesso, rafforza la concezione di se. Distinguersi per non inquinarsi. Sentirsi inespugnabili eticamente, ristora la definizione morale della propria personalità. Attaccare e demonizzare chi invece ha ceduto (consenziente o meno, volente o meno) non dissipa le paure, permette solo di derubricare le colpe degli aguzzini. Ed è assolutamente inutile.
Chiunque desideri approcciarsi in un simile dibattito di dolore e di squallore, deve spogliarsi delle proprie convinzioni, condizioni e facilitazioni guardando con sincerità alle debolezze umane, riflettendo su se stessi con onestà e sugli altri con indulgenza.
Il resto non serve.