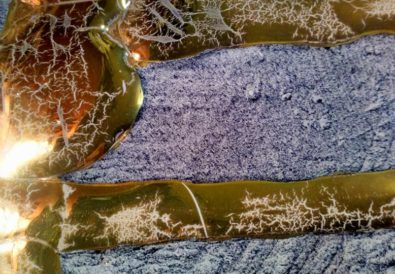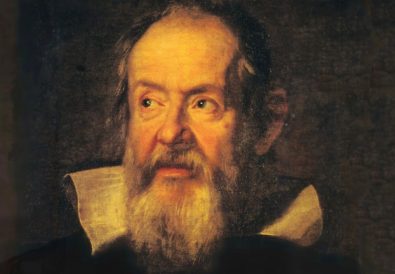Era stato accolto con 12 minuti di applausi al Festival di Cannes e in effetti di fronte al biopic su Elvis Presley firmato Baz Luhrmann si resta incantati.
Baz Luhrmann è noto per i suoi retelling di grandi classici – Romeo e Giulietta, La Traviata (e quindi La dama delle camelie), Il grande Gatsby, per citarne alcuni – che non sono mai né puro intrattenimento né pura tragedia: camminano con eleganza sul filo della malinconia, con un passetto ammaliano e con un altro commuovono, sospendono la tensione con una risata e poi tornano a colpire nel vivo, ma con mesta dolcezza, le nostre umane fragilità. Per molti versi sono assimilabili al concetto di sublime: c’è sempre un mondo, nelle storie dirette da Baz Luhrmann, che sovrasta e inghiotte i protagonisti i quali, come nel teatro tragico greco, sembrano destinati ad una fine ineluttabile, che si scrive, progressivamente ma in modo inesorabile, man mano che la storia procede e che il mondo agisce sui protagonisti, che in quel mondo così fuori dalla loro portata prendono forma, compiendo sé stessi e il loro percorso – giungendo infine alla loro destinazione – di fronte agli occhi dello spettatore, il quale come un Viandante sul mare di nebbia di spalle sulla sua poltrona osserva forze irreversibili agitarsi sull’animo e scatenarsi sull’esistenza del protagonista. Perché, allora, darsi la pena di assistere ad un viaggio il cui ultimo capitolo si scrive, lentamente, sin dal primo atto? Perché i personaggi dei suoi film sono incarnazioni di epopee dell’animo, di rivolgimenti ed evoluzioni che hanno l’atmosfera rarefatta dell’epos e la schiettezza della realtà.
Il re del rock ‘n’ roll è perfettamente colto nelle sue movenze più sottili – tanto fisiche quanto emotive –da Austin Butler, che lo interpreta senza inciampare neanche una volta nell’esagerazione, ben diversa dall’eccesso che contraddistingueva l’immagine del cantante; ogni sguardo e ogni sorriso, ogni espressione è perfettamente calibrata su un’attentissima osservazione del materiale audiovisivo disponibile. L’attore dà forma udibile alla parte più profondamente umana di Elvis modulandone le diverse voci: da quella più veloce e agitata delle prime esibizioni a quella calma e consapevole che sa di potersi prendere tutto il tempo, anche quello di cui non ha bisogno, perché sa di tenere l’audience, che sia sul palco o meno, sul palmo della mano; una voce che diventa via via più spenta man mano che il lutto, la separazione, le delusioni, l’esaurimento delle forze fisiche si fanno strada nel concentrato di energia che vediamo all’inizio del film, un’energia che verrà sempre più inquinata dall’ambiente, dal sedicente colonnello Parker in primis, dalla fama, dagli affetti, ma che mai perde la sua forza: particolarmente efficace, sotto questo punto di vista, la scelta di inserire un primissimo, strettissimo piano della – vera – performance del giugno ’77, quella Unchained melody che trasforma la voce di un uomo esausto, che fino a qualche attimo prima di cantare sembrava aver utilizzato tutte le forze che aveva, in un momento vocale di piena potenza; il brivido che ci percorre non è dato dalla consapevolezza che di lì a pochissime settimane quella voce si sarebbe spenta per sempre: al contrario, abbiamo l’impressione precisa e fulminante, trascinati dall’energia di quel volto intensamente immerso nella sua musica e dalla potenza pura della sua voce, di essere di fronte a qualcosa di eterno.
Il soggetto, ha, poi, secondo il regista, una valenza tutta attuale. Gli Stati Uniti nei quali è vissuto Elvis sono alla base di quelli attuali e due temi emergono con chiarezza nel corso dell’intera pellicola. In primis il razzismo, illustrato nei fatti e rimarcato dalle parole del film sin dalle primissime battute: basta che qualcuno sveli che “He’s white” e immediatamente la canzone che fino a quel momento era stata accolta
dall’indifferenza più totale (venata anzi da un mal celato fastidio) e relegata a piacevole sottofondo perché interessante, sì, ma non degna di essere presa davvero in considerazione – al colonnello Parker, infatti, “sembra, sentendolo, un ragazzo nero” – si passa ad un ascolto minuzioso e alla conseguente corsa da parte di tutti verso la Louisiana Hayride perché se era bianco allora sì, aveva diritto a tutta la loro attenzione e perché Parker sapeva – motivo per il quale i suoi occhi si illuminano alla rivelazione che a fare musica coinvolgente ed interessante come quella black (come disse Elvis Presley stesso nel ’68, moltissima musica rock ‘n’ roll, anche quella in quel momento contemporanea, non è altro che gospel e rhythm and blues) fosse, per una volta, un ragazzo bianco – che in quanto tale anche un largo pubblico sarebbe stato ben disposto ad ascoltarlo, qualcosa che, come dimostra l’assoluta indifferenza iniziale, ad un ragazzo nero sarebbe stato – ed era sistematicamente – negato in partenza; più avanti nel film B. B. King, di fronte al “They wanna put me in jail” di un Elvis che era stato bruscamente invitato dalle reti televisive a limitare le sue mosse giudicate oscene (e non adatte agli investimenti pubblicitari), gli fa notare senza mezzi termini che avrebbero potuto incarcerare o uccidere lui, se solo avesse attraversato la strada e a loro non fosse piaciuto, ma che di certo il bianco (e per di più redditizio) Elvis non rischiava assolutamente nulla; quando, durante l’esibizione di Little Richard in quella stessa serata, Elvis entusiasta dice quasi senza pensarci di voler incidere quella canzone, gli viene risposto che se lo avesse fatto avrebbe potuto guadagnare “più di quanto quel ragazzo avrebbe mai potuto immaginare”.
L’altro tema portante del film – la cui struttura è, in effetti, una dialettica tra Elvis e il sedicente colonnello Parker, tra l’essere umano e il mondo (incarnato dalla figura del colonnello) che agisce senza pietà su di lui, senza curarsi degli effetti devastanti e senza gioire di quelli positivi, tra Atlante e il globo che lui sorregge e che lo schiaccia – è quello – anch’esso attualissimo – della vendita di sé, del profitto a tutti i costi, del capitalizzare alla massima velocità e a scapito di qualsiasi cosa, della serenità e persino della vita stessa. L’uso degli spazi – sempre interessante in Baz Luhrmann – specialmente quelli più alti, suggerisce in modo tanto efficace quanto angosciante la solitudine, la mancanza di una via d’uscita, la prigione a vetri nella quale si è confinati nonostante l’illusione di abbracciare tutto con lo sguardo, di poter arrivare dappertutto, tanto che quando Elvis (il personaggio) cede al ricatto del colonnello, il primo del quale è realmente consapevole, lo fa oscurando tutte le finestre della sua suite all’International di Las Vegas, deciso ad eliminare quella falsa prospettiva di libertà dalla gabbia nella quale ora sa di essere stato relegato; una presa di coscienza visivamente potentissima. La dinamica sempre più stringente della manipolazione è ben esemplificata, tra le molte declinazioni, dall’illusione sempre alimentata e ogni volta inappagata di un tour al di fuori degli USA. Il contrasto tra gli speciali di Natale (esiste qualcosa di più commerciale?) e la volontà, novità e creatività artistica, tra i film realizzati e le velleità recitative, l’iniziale bilanciamento tra vendita e arte (la presenza del merchandise è uno degli indizi offerti allo spettatore) e il graduale svuotamento a favore del guadagno, la voce dell’artista che nel dietro le quinte diventa sempre più sfumata fino quasi a svanire nella sordità sempre più sfacciata del colonnello e del padre di Elvis; uno scontro sempre più stridente che vediamo acuirsi fino a diventare insopportabile.
Una ricostruzione che non è una sterile e meccanica ripetizione di ciò che è stato. Baz Luhrmann ha catturato l’essenza di una vicenda umana eccezionale, alla quale il cast ha saputo dar vita con la grazia del racconto e la schiettezza della realtà, ha mescolato registri diversi con assoluta maestria, ha curato ogni dettaglio e al tempo stesso si è concesso una licenza laddove essa ha permesso una narrazione più efficace, il tutto senza mai tradire la memoria, lo spirito e la storia della persona e del personaggio che l’hanno ispirata. Una poesia scatenata e silenziosa, fragile e dirompente.